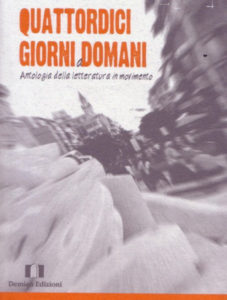
La decoratrice di cappuccini
(tratto da “Quattordici giorni a domani””, AA. VV., antologia a cura di Luisa Gasbarri, Demian Edizioni, Teramo 2006)
“Un cappuccino, grazie”.
La frase più comune che sentiva rivolgersi. Frase tra labbra umide di sudore di contorno, se di estate, un po’ frammentata con i denti a battersi, nell’inverno.
Anche se poi dove l’orizzonte diviene il mare non è che faccia troppo freddo d’inverno. E’ un evento quando nevica, almeno a queste latitudini. E si fermano i marciapiedi, si fermano le vie e stanno a naso in su esterrefatti e un po’ bambini. Almeno all’inizio. Prima che il caos improvvisi nella mancata accoglienza dell’evento.
“Un cappuccino, grazie”.
E lei. Ci pensava sempre. Alla voce. Alle voci. Già quando glielo chiedevi ti si instradava dentro. Nel tuo essere di ogni giorno finanche nel tuo particolare stato del momento.
Voci. Timbri. Toni.
L’alchimia dei particolari. Spunti irrisori a far importante una giornata. Colta per sfumature o insignificanze, per molti. Ma non per lei. Che della vita tecnica ne sapeva poco. Ma l’essenziale, quello sì, quello lo conosceva, lo carpiva. Ed è una dote quando si riesce in ciò, anche se apparentemente non sei una pedina fondamentale nella scacchiera della tua città, di questa città che dovrebbe crescere e non dovrebbe perdersi, in quegli incroci di automobili scorbutiche, sui quei marciapiedi accostati al mare, spalle al vento che sembra sempre volerti sradicare e portare via quando l’estate si stempra velocemente nell’inverno, con autunni in veloce passaggio e solo d’intermezzo. E si incontrano tanti personaggi. Non una metropoli, non possibilità che può darti una Roma o Milano o Napoli o Firenze o Bologna o tante altre. Ha il suo. Dosato, ristretto. Forse stretto. Che manca spesso di qualcosa, non basta, è provinciale, è piccola, ha nulla. Anche quando ha qualcosa.
Ha grandi e strani fiori tutti allineati e variopinti che spuntano da un giorno all’altro verso Giugno, che di notte si richiudono al contrario in quel petalo unico e circolare, fiori che altrettanto repentinamente svaniscono nella sabbia verso Settembre. Lasciando sabbia, appunto, solo sabbia, come nella maggior parte dell’anno la striscia di deserto, un limbo tra mare e asfalto.
Ha la gente. Ovvio, è una città, non una metropoli. Ma ha la gente. E’ una città d’altronde. Ha un via vai. Attraverso autostrade, binari, aerovie, rotte navali. Il particolare e le persone, da dentro a fuori le persone, saper trovare intorno, vedere e apprezzare. Da trovare dentro, nell’intimo. Esterno intimo. E viceversa.
E la decoratrice di cappuccini. Aveva anche lei. Lei che amava semplicemente star lì dietro quel bancone, fare soprattutto cappuccini. La sua forma d’arte. Ognuno ne ha una.
Le piaceva scorgere oltre i lineamenti del cliente di fronte, trovare quindi il movimento del mare a volte interrotto dalle auto solcanti la striscia d’asfalto che costeggia quella massa d’acqua sempre diversa, viva, cangiante. Affascinante anche quando brutale e accesa e squarciata magari da lampi e con un copricapo plumbeo di nubi e lo sbuffo insolente ad aiutare mare stesso a gonfiarsi e annientarsi in spuma contro gli scogli. Per poi tornare, deviare, ancora abbattersi. Instancabilmente per lui, mare, e per lei, osservatrice poetica.
La sua arte. Osservare e fare cappuccini.
La sua passione. Fuggire a volte in treno.
Lungo la costa adriatica o dentro le montagne. Sballottata da quelle carrozze troppo calde d’estate e troppo fredde d’inverno. Vecchie. Diligenze poco indulgenti con i propri passeggeri, verso l’interno soprattutto, in un paesaggio statico, non come il mare, ma anche in grado di cambiar veste. A seconda dei mesi. Mutando lento, ma per ampie distese e picchi.
Viaggiava, come tanti, ma per non arrivare, bensì per tornare sempre. E quando viaggiava scriveva. Appuntava tutto quel che interagiva con il suo vivere. Parole, volti, lacrime, rumori, spigoli, colori, ombre. Riversava sé stessa, acquisiva sensazioni e le immortalava, scritte.
Dietro quel bancone anche. Ma diversamente. La sua arte in forma materiale. Immagazzinava. Sembrava che non ne avesse mai abbastanza, che non avrebbe mai barattato quel lavoro che occupava quasi a tempo pieno. Immagazzinava. Custodiva la gente e il suo mare. E creava.
La sala mostre era il bancone stesso del bar. Il laboratorio il suo lato, al di là. Gli strumenti, la macchina del caffè e un cartoccio fatto a cono pieno di cioccolata da spremere e gestire come un pennello. Il punto di vista migliore era uno solo, quello del pagante. Quello di chi gli aveva commissionato il lavoro, con gomiti poggiati sul marmo dell’oblungo bancone, schiena appena ricurva in avanti, occhi dallo sguardo perpendicolare alla tela di schiuma dentro la tazza. E ci si restava un’infinità di infinite frazioni di attimi ad ammirare l’opera.
Tutti lo facevano, rapiti involontariamente e in modo mite. Anche chi solo ordinava un cappuccino tanto per sciacquarsi di caldo latte e caffè le budella poi finiva per restarne intrappolato. E c’è chi giura di essersi innamorato di fronte a quei cappuccini, di fronte a quei disegni. Perché parlavano di te. Ti ritrovavano. Avveniva che la decoratrice di cappuccini ti accoglieva e ti adagiava privilegiato al tuo evento unico già solo con i suoi tondi specchi scuri e languidi, tu dicevi solo “un cappuccino, grazie”, come sempre, e lei ti sfiorava con quegli occhi grandi, senza malizia, ti sfiorava lungo le guance, gli zigomi, a scivolar tra i capelli e sprofondare oltre, nel mare. Era un attimo.
Attimi.
La vita è fatta di attimi che a volte, uniti, non sono che attimi più grandi, ma sempre attimi, indelebili però, unici, importanti, ricchi di qualcosa di peculiare che li fanno diventare un oblio indefinito e per sempre, eoni di magnificenza.
E in quel mentre già ti aveva afferrato. Dentro. E carpito il tuo mare. Contrastato con quello eterno e fluttuante oltre la litoranea, a due passi più in là, contrastato quando dal tuo viso passava oltre. Per poi tornare.
Attimi.
Tornare, dietro quel bancone.
E poi lo creava il tuo mare, proprio il tuo. Il tuo. Il rumore della macchina per la schiuma, rumore soffice, quasi di un altro sistema dinamico di fluidi, coi propri spostamenti e rimescolamenti, col suo proprio fruscio, racchiuso poi in una tazza di ceramica. Fruscio a giungere al tuo udire e poi alla tua vista privilegiata di pagante.
Il fruscio del mare, quello tuo. Il fruscio della sua poesia, quella che prendeva forma in superficie e diveniva arte.
Una tela bianca sotto i tuoi occhi. Le sue mani chiare dalle dita sottili a premere un cartoccio e disegnare su quella soffice tela. E chi ci si è innamorato ha trovato qualcosa sopra quella schiuma. E non un semplice cuore. Una donna e un uomo, due cappuccini, due tele di schiuma. Due opere accostate, di cioccolata. Tempesta nel mare di lui e un bagliore a lato. Un sole e raggi verso quella tempesta, dalla tazza di ceramica della donna a quella dell’uomo, raggi a rischiararla, a dare un segnale. Chi ci si è innamorato nella decoratrice di cappuccini ha trovato un volto pulito e semplice, immerso in due anime al di là del bancone, ansioso di apprendere se il suo donarti tutto ciò che era in un disegno di cioccolata era stato gradito.
E’ solo un angolo, un rifugio, un allietarsi, un iniziare la giornata o terminarla. Quel bar potrebbe trovarsi qui come ovunque. Potrebbe. Ma è qui. Riequilibra quel che manca. Forse non è l’unico, magari si perde nei tanti centri commerciali, dietro ai clacson che sbuffano in attesa del verde, vicino a un senegalese che si riposa poggiato a un muro, tra le vetrine delle boutiques o al porto tra i pescatori che risistemano le reti. Quel bar, con la decoratrice di cappuccini dentro, unico. O forse no. E’ quel che conosco. Non è tutto. Solo un bar e una ragazza.
E io. Ci andavo da più di un anno, abitualmente. E lei. Ne ha composte di opere per me, avevano il disegno e la musica. Musica nei rumori mansueti della creazione. E le parole, tutte in quella dolce materializzazione. C’erano anche le parole in tutto ciò, quelle mai dette, quelle nascoste nei suoi polpastrelli, nelle movenze, negli occhi, nei sapori.
Una mattina disegnò per me un fiore. Lo stelo leggermente curvo da un lato e le due foglioline, il cerchio al centro e i petali arrotondati alle estremità. Un fiore, tutto qui. Ma era la prima volta che mi offriva dei fiori mettendoli a bagno in quel latte e caffè. Aspettai come sempre che si immergessero da soli nel liquido miscelato, quindi li colsi, a piccoli sorsi, ne gradii il profumo, li masticai con il cuore assorbendone il nettare. Fu una giornata come tante altre eppure diversa. Era la prima volta che mi regalava dei fiori. E io li accettai e ringraziai, con un sorriso. Un’altra volta, invece, disegnò il mare. Ma sembrava proprio quello che avevo alle spalle. Un tardo pomeriggio a cavallo tra autunno e inverno, con poca luce, un vento forte e gelido che piegava le palme ai margini della strada. Un tardo pomeriggio di una giornata cupa assente di sole anche al mio interno. Disegnò, per me, il mare che alle mie spalle era in burrasca, scagliato assordante, infrangente sé stesso contro gli scogli, iracondo a divorar la riva, a sfidare finanche il bitume e le prime abitazioni ostentando la furia e la possibilità di poter inglobare tutto e senza limiti in qualsiasi momento avesse voluto. Un mare, quel giorno, che era come io anche mi sentivo. E magari quella volta per la decoratrice di cappuccini il contrasto tra me e lui fu solo un riconoscermi in quell’agitarsi e abbattersi sugli scogli, su quella fissa platea di estati e di inverni. Così gradii, anche in quella occasione, perché fu come una confidenza, un essermi liberato di un peso, delle mie preoccupazioni, dei miei drammi. Mi fece piacere, anche quella volta. Lei mi aveva ascoltato, aveva compreso, discreta e semplice. Tutto così, senza parola alcuna, neanche quella di rito. Che di parole, in effetti, ne avevamo sempre scambiate poche, le solite. Io, il mecenate. Lei, l’artista che dipingeva su un cappuccino proprio ciò di cui necessitavo.
Poi.
Un giorno.
I giorni nascondono sempre ciò che non è ancora avvenuto, spesso ciò che non vorresti accadesse, ciò che a volte accade cogliendoti impreparato.
Poi.
Un giorno.
Lei.
Correre in lacrime dentro la stazione.
Un mare è inarrestabile. Un mare nel suo essere impetuoso è pietoso se devia verso altro e scappa via e non ti travolge. Un mare, a volte, scappa. Con la sua profondità e la sua insondabilità.
Mi trovavo alla stazione centrale in attesa del treno per un viaggio di lavoro. La intravidi tra la folla di fine domenica, fatta di militari che tornavano o forse partivano, invadenti quasi tutto l’atrio, una folla anche di tanti altri viaggianti. L’inverno era passato, le stagioni si accorciano, capita che a Febbraio i peschi già siano in fiore. E che magari poi torni il freddo. Io pensavo all’impegno dell’indomani mattina. E ai suoi fiori. Ed ecco. La vedo correre, piangente, mi passa a poca distanza, non mi nota nemmeno. La seguo con lo sguardo, raramente l’avevo vista fuori dalla sua sala mostre e non mi aspettavo di ritrovarla lì, in quel momento, in quelle condizioni. Fugge, urta gente incurante di lei. E le cade un taccuino di sensazioniparole. Fu un attimo. Lo raccolsi subito quel taccuino, cercai quindi di raggiungerla ma le molteplici mimetiche fecero il loro dovere. La mimetizzarono. Si diluì in lacrime tra quelle divise, non riuscii neanche a capire verso quale binario.
Scomparve. Così. Per sempre.
Pescara è un porto, un’autostrada, un aeroporto, una stazione ferroviaria. Mare, asfalto, rotaie. Via vai di vite e valige e pensieri e timori e speranze. Come in tante città. Pescara è un moto continuo nel suo piccolo. Si sbarca a Pescara e ci si imbarca altrove, con ogni mezzo, nella sua dimensione cittadina. Stretta, insufficiente. Abbastanza, troppo anche. Con i pensieri del lavoro, tutto quel che offre la città, tutto quel che si vorrebbe. Pensieri. C’è chi ignora che le città di mare esistano anche d’inverno. Pensieri. Tanti. Ma niente paura. Così per lei che se ne è andata. Chissà in quale luogo, la decoratrice di cappuccini. Niente paura, che non serve. Solo la malinconia, solo le delusioni, solo il sogno utopistico di raggiungersi. Che a inseguirsi non si finisce mai quando dentro si ha tanto e forse troppo. E il problema di fuggire è che porti sempre te stesso con te.
E forse è un bene. Forse è un male. Ma tante volte è tutto ciò che hai. Ed è già qualcosa. E allora. Niente paura. L’ho visto, nelle sue lacrime, anche se erano lacrime e non sorrisi. Anche se era una fuga, la sua.
Niente paura.
E io. Io eccomi qua. Niente più disegni di cioccolata. Ogni tanto ci torno in quel bar ma non con la frequenza di prima. E i volti. Che prima bene o male ci si conosceva tutti di vista quelli che andavamo lì. Tutti per lo stesso motivo. Tutti orfani di qualcosa, adesso. Volti nuovi. Ogni tanto torno e ordino un cappuccino e la ragazza che c’è adesso è anche simpatica. Dà confidenza, fa battute, ti ascolta. Mi sorride. Le sorrido. Ma ha un sapore diverso il mio sorriso. E’… il solito, grazie. E il bancone non è più una galleria d’arte di marmo per dipintisentimenti che durano istanti brevi e irripetibili in una tazza di ceramica. E le macchine sul lungomare sono tutte uguali. La macchinetta della schiuma è addirittura fastidiosa se provo a cogliere di nuovo quel particolare fruscio, eppure è la stessa e… il mare… no, quello no… muta sempre. Sempre. Affascinante.
E in lui ancora sento ondeggiare gli occhi di lei, di quando per delle frazioni di tempo scivolavano sul mio viso e mi immergevano, a carpirmi e capirmi, tra quelle onde, oltre. A disegnarmi attraverso le sue mani.
E ancora, il suo taccuino. Quello raccolto. Quello che custodisco, che spero un giorno di ridarle. Quello che dentro di me so che non tornerà mai più tra le sue mani. Dal suo taccuino di tanto in tanto la leggo. E viaggio, con lei, in quei treni che prendeva per andare a tornare. Sensazioniparole. Pagine un po’ arricciate dalla penna che le ha scalfite. Ne apro una a caso. In questa città media, fermo, seduto nei pressi del faro che entra nel mare, dove il fiume si allargamare. E sull’orizzonte non è più estate e l’inverno forse arriverà quanto prima con le stagioni in mezzo che appaiono, si sciupano veloci e riemergono improvvise. Leggo alcune pagine, prima di lasciarmi a qualche vicolo, lampioncini e luce gialla, qualche insegna accesa, rumore di macchinari da bar. Ricerca di una decoratrice di cappuccini.
Novembre. Treno da Pescara per Roma delle 18:40.
Lacrime.
Io appunto, ho iniziato appuntando. Scrivendo. Mi piace
scrivere d’altronde. Ma come si può fare. No perché mica è
sempre così facile.
Lacrime.
Possono essere descritte, scritte, impresse delle lacrime? Che
hanno della loro consistenza, un loro essere. Materiale. Un
treno è capace di cullare frasi senza senso, persone senza senso,
eventi senza senso. E’ indifferente. Se ne sbatte di chi ha dentro
mentre scivola sui binari.
Porta.
Porta gente, il treno.
Mentre fugge.
Porta anche un senso assoluto. Come quello racchiuso nelle
lacrime di una persona.
C’è una ragazza, un paio di posti più in là, avrà la mia età,
cela il suo viso piangere, o almeno ci prova. Fa per accendersi
una sigaretta, ma non si può fumare in treno, è vietato, ne è
consapevole.
E ondeggia con il treno che ondeggia in corsa. E ondeggia, un
po’ assente, ma in qualche altro modo presente, ondeggia nella
sua consapevolezza.
La ragazza prende i suoi bagagli, la sigaretta non è accesa, va
in fondo alla carrozza traballante di poche vite stasera, va in
fondo al vagone con un disappunto che prescinde dalla
sigaretta: non è lei fuori luogo, in quel luogo in movimento che
ne attraversa altri che gli scivolano intorno. Non è lei fuori
luogo, sono i pochi altri presenti, sono i vincoli. I vincoli della
vita. Ecco cosa.